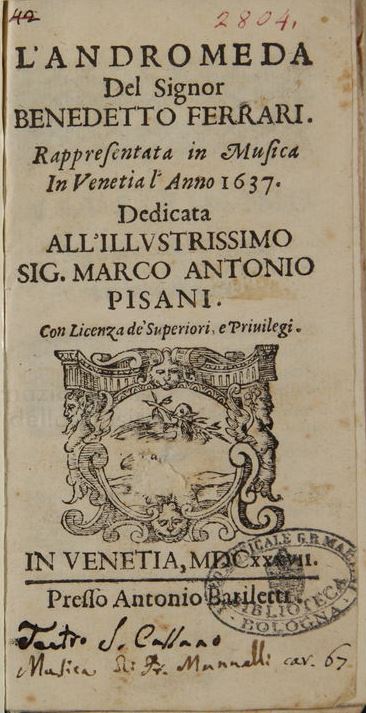L’Andromeda
Rappresentata in musica
Libretto di Benedetto Ferrari
Musica di Francesco Manelli
Prima esecuzione: carnevale 1637, Venezia, Teatro San Cassiano.
Interlocutori:
| GIUNONE | soprano |
| MERCURIO | tenore |
| ANDROMEDA | soprano |
| NETTUNO | basso |
| PROTEO | basso |
| ASTREA | soprano |
| VENERE | soprano |
| ASTARCO mago | basso |
| GIOVE | basso |
| PERSEO | tenore |
| ASCALÀ cavalier di corte | tenore |
Coro di Ninfe arciere. Coro di Ninfe danzatrici. Coro di Dèi nel cielo.
La scena si finge una spiaggia di mare nell’Etiopia.
Libretto – L’Andromeda
Illustrissimo signore, e padron colendissimo
Andromeda, che fu su le scene, rinacque già son due mesi; su le glorie de’ suoi natali, esce ad accrescersi negl’applausi dell’universo: nell’introdurla con le mie stampe mi son proposto d’assicurarla sotto l’ombra d’un protettore; a fin che principessa sì gloriosa abbia nel nuovo secolo chi l’affidi dall’antiche sciagure. V. s. illustrissima è la scelta a difenderla da gl’infortuni, stimandola via più sicura sotto il suo nome, che sotto la tutela di Giove. L’autore, che ripieno d’ogni virtù, ha potuto nel teatro da sé stesso illustrarla in ogni parte di nobiltà; dopo averla liberata dallo sdegno di Giuno, e sublimatala su le sfere, non avrà forse a desiderarli altra felicità, che di vederla raccolta da un animo generoso. M’assicuro, ch’avrà il godimento che brama, persuadendomi, che ella non sia per stimare minor lode tra gli onori di tanti impieghi, l’essere in questo parto liberale della sua grazia. Con dedicarmeli devotissimo, resto ad augurarli ogni vera prosperità.
Di Venezia, lì 6 maggio 1637.
Di v. s. illustrissima
umilissimo servitore
Antonio Bariletti
Lo stampatore a’ lettori
A gloria de’ signori musici, ch’al numero di sei (coll’autore collegati) hanno con gran magnificenza, ed esquisitezza, a tutte loro spese, e di qualche considerazione, rappresentata l’Andromeda, e per gusto non meno, di chi non l’ha veduta, ho firmato cosa convenevole il farne un breve racconto in questa forma.
Sparita la tenda si vide la scena, tutta mare; con una lontananza così artificiosa d’acque, e di scogli, che la naturalezza di quella (ancor che finta) movea dubbio a’ riguardanti, se veramente fossero in un teatro, o in una spiaggia di mare effettiva. Era la scena tutta oscura, se non quanto le davano luce alcune stelle; le quali una dopo l’altra a poco a poco sparendo, dettero luogo all’Aurora, che venne a fare il prologo. Ella tutta di tela d’argento vestita, con una stella lucidissima in fronte, comparve dentro una bellissima nube, quale ora dilatandosi, ora stringendosi (con bella meraviglia) fece il suo passaggio in arco per lo ciel della scena. In questo mentre si vide la scena luminosa al par del giorno. Dalla signora Maddalena Manelli romana fu divinamente cantato il prologo: dopo del quale s’udì de’ più forbiti sonatori una soavissima sinfonia; a questi assistendo l’autore dell’opera con la sua miracolosa tiorba. Uscì di poi Giunone sovra un carro d’oro tirato da’ suoi pavoni, tutta vestita di tocca d’oro fiammante, con una superba varietà, di gemme in testa, e nella corona. Con meraviglioso diletto de’ spettatori, volgeva a destra, ed a sinistra, come più le piaceva, il carro. Le comparve a fronte Mercurio. Era, e non era, questo personaggio in machina; era, perché l’impossibilità non l’ammetteva volatile; e non era, poiché niun altra machina si vedea, che quella del corpo volante. Comparve guarnito de’ suoi soliti arnesi, con un manto azzurro, che le giva svolazzando alle spalle. Fu eccellentemente rappresentata Giunone dal signor Francesco Angeletti da Assisi; e squisitamente Mercurio dal signor don Annibale Graselli da Città di Castello. In un istante si vide la scena, di marittima, boschereccia; così del naturale, ch’al vivo al vivo ti portava all’occhio quell’effettiva cima nevosa, quel vero pian fiorito, quella reale intrecciatura del bosco, e quel non finto scioglimento d’acque. Comparve Andromeda con il séguito, di dodici damigelle, in abito ninfale. L’abito d’Andromeda era di color di foco; d’inestimabile valuta. Quello delle ninfe era d’una leggiadra, e bizzarra divisa a bianco, incarnato, e oro. Rappresentò mirabilmente Andromeda chi fece il prologo. Tornò in un momento la scena, di boschereccia, marittima. Comparve Nettuno, e gli uscì Mercurio nella sua mirabil machina all’incontro. Era Nettuno sovra una gran conca d’argento, tirata da quattro cavalli marini. Lo copriva un manto di color celeste; una gran barba gli scendeva al petto, e una lunga capigliatura inghirlandata d’alga le pendeva sulle spalle. La corona era fatta a piramidette, tempestata di perle. Fece questa parte egregiamente il signor Francesco Manelli da Tivoli; autore della musica dell’opera. Uscì dal seno del mare, dalla cintola infuso, Proteo, vestito a squame d’argento; con una gran capigliatura, e barba di color ceruleo. Servì di questo personaggio gentilissimamente il signor Gio. Battista Bisucci bolognese. Qui per fine dell’atto si cantò prima di dentro un madrigale a più voci, concertato con strumenti diversi; e poi tre bellissimi giovinetti, in abito d’Amore, uscirono a fare, per intermezzo, una graziosissima danza. Il velocissimo moto, di questi fanciulli talora fece dubbiose le genti, s’avessero eglino l’ali a gli omeri, o pure a’ piedi. A tempo d’una melliflua melodia di strumenti, comparvero Astrea nel cielo, e Venere nel mare. Una entro una nube d’argento; l’altra nella sua conca, tirata da cigni. Era vestita Astrea del color del cielo, con una spada a fiamme nella destra. Venere del color del mare, con un manto d’oro incarnato alle spalle. Fu graziosamente rappresentata Astrea dal signor Girolamo Medici romano, e Venere soavissimamente dal signor Anselmo Marconi romano. Si mutò la scena in boschereccia, e uscì Andromeda con la sua schiera. Sei delle sue dame, qui per allegrezza dell’ucciso cinghiale, fecero un leggiadro, e meraviglioso balletto; con sì varie, e mirabili intrecciature, che veramente gli si poteva dar nome d’un laberinto saltante. Ne fu l’inventore il signor Gio. Battista Balbi veneziano, ballarino celebre. Uscì repente di sottoterra Astarco mago, com’ombra. Era questo personaggio tutto vestito a bruno d’oro, in veste lunga, con capigliatura, e barba lunga e come neve bianca. Scettro di negromante, reggeva la destra una verga. Rappresentò degnamente questo soggetto chi fece Nettuno. S’aperse il cielo, e in uno sfondo luminosissimo, assisi in un maestoso trono, si videro Giove, e Giunone. Era Giove coperto d’un manto stellato; sosteneva la chioma una corona di raggi, e la destra un fulmine. Rappresentò celestemente questa deità chi fece Proteo. Qui per fine dell’atto si cantò prima di dentro un altro madrigale a più voci, concertato con strumenti diversi; e poi dodici selvaggi uscirono a fare, per intermezzo, un stravagantissimo, e gustosissimo ballo di moti e gesti. Non vi fu occhio che non lagrimasse il transito di questa danza. Ne fu inventore il signor Gio. Battista Balbi ballarino suddetto. Si cambiò la scena in marittima; a tempo d’una dolcissima armonia di strumenti diversi comparve da un lato della scena, una bellissima machina con Astrea, e Venere suso. Volgevasi al destro, ed al sinistro lato, come più a quelle deità aggradiva. Le uscì dirimpetto a Mercurio; e aprendosi il cielo assisté Giove nel mezzo. Fece un meraviglioso effetto questo scenone, per la quantità delle machine, e per lo successivo ordine della comparsa, e della gita. In un baleno divenne la scena marittima un superbo palagio. Fu bello e caro il vedere da rozzi sassi, e da spiagge incolte nascere d’improvviso un ben disegnato, e costrutto edificio. Figurava questi la reggia d’Andromeda, dalla quale uscì Ascalà cavaliere. L’abito di costui eccede di valuta, e di bellezza, quello di ogni altro. Comparve vestito all’usanza turca. Con mille grazie di paradiso rappresentò questo dolente personaggio chi fece Mercurio. Di repente sparito il palagio, si vide la scena tutta mare con Andromeda legata ad un sasso. Uscì ‘l mostro marino. Era con sì bello artifizio fabbricato quest’animale, che ancorché non vero, pur metteva terrore. Tranne l’effetto, di sbranare, e divorare, avea tutto di viso, e di spirante. Venne Perseo dal cielo sul Pegaso, e con tre colpi di lancia, e cinque di stocco fece l’abbattimento col mostro, e l’uccise. Era questo personaggio d’armi bianche vestito, con un gran cimiero sull’elmo; e una pennacchiera all’istessa divisa aveva il volante destriere su la fronte. Fu rappresentato questo soggetto angelicamente da chi fece Ascalà. S’aperse il cielo, e si videro Giove, e Giunone in gloria, e altre deità. Scese questo gran machinone in terra, accompagnato da un concerto di voci, e di strumenti, veramente di paradiso. Levati i due eroi, che fra di loro complivano gli condusse al cielo.
Qui la regale, e sempre degna funzione ebbe fine. Vivete sani.
Del padre sig. don Alfonso Pucinelli
All’autore, poeta, musico, e sonator di tiorba eccellentissimo.
Non più fra’ suoi confini il basso polo
provò di meraviglie un sforzo altero;
ch’entro salma mortal dall’emisfero
chiudesse un divin spirto sceso a volo.
Ceda omai ceda ogni lodato stuolo
de la prisca virtù; doni l’impero
di primato al miracolo più vero,
ch’il ciel ammira, e idolatra il suolo.
Scriva, o suoni la man; celesti lire,
paradisine frasi (ah ch’io no ‘l celo)
benedetto quaggiù ne fa sentire.
O felice stagion in mortal velo!
Angel udir senza di vita uscire,
goder quaggiù quel, che si gode in cielo.
Del sig. dottore Bartolomeo Angarani
All’autore.
Mentre su molle, e delicata cetra
la man gentil va fabbricando oggetto
all’orecchio mortal, gran Benedetto,
sovr’umano gioir a quello impetra.
Mentre regia beltà, che non s’arretra
ad altro bel, di questo uman ricetto,
spiega de la tua penna il stil perfetto
ogni vena riesce oscura, e tetra.
Godi di doppio vanto adunque il pregio;
della man, de la penna alto valore
a la fama t’invola eterno il fregio.
Quinci amico a virtù t’ama ogni core,
e con ragion; che nel tuo sen egregio
la gloria ha ‘l tempio, e la sua reggia onore.
Del signor Gio. Francesco Busenello
All’autore.
Oltre le sfere, ove di sol vestito
passeggia il sempre con la gloria a lato,
ove l’altrui memorie eterna il fato,
il tuo nome (o Ferrari) è già salito.
De la tua Andromeda invaghito
Apollo tutti i lumi suoi t’ha dato;
e di tua fama l’infaticabil fiato
col perpetuo de’ cieli ha il giro unito.
Nel lume, di tue lodi io pur vorrei
le mie muse abbellir; ch’il tuo tesoro
può circondar di perle i versi miei.
Parnaso in te conosce il suo decoro;
e con ragione un Benedetto sei,
se del tuo ferro un idolatra è l’oro.
Sonetti del signor Benedetto Ferrari
In lode de’ signori musici più celebri, ch’intervennero nell’Andromeda.
Al sig, don Annibale Graselli da Città di Castello;
che rappresentò Mercurio, Perseo, ed Ascalà.
Se pronto ambasciator per l’aria a volo
ne givi a cenni, di alcun nume, o diva,
da dolce impeto tratti ti seguiva
d’anime, e cori innamorati un stuolo.
Se dall’alto scendevi eterno polo,
e ‘l mostro reo la lancia tua feriva,
la tenzon sì mirabil riusciva,
che facevi gioir fra l’armi, e ‘l duolo.
Se spiegavi il tuo dir, nunzio dolente,
fin da le selci ne traevi il pianto,
non che dagl’occhi dell’umana gente.
Di due grandi Annibal diasi pur vanto
la prisca etate, il secolo presente,
l’un nell’armi divin, l’altro nel canto.
Per l’Andromeda
Del sig. Benedetto Ferrari; rappresentata in Venezia.
Parti fuor d’Etiopia, e fermi il piede,
ov’han liberi eroi su l’onde il regno
(peregrina infelice) e l’atto indegno
de le sventure tue teco ne riede.
Svelto il lido a seguirti esser ti crede,
e qual scena, di Giun serve a lo sdegno,
ch’in te, diva al poter, fera all’ingegno,
numi, e mostri eccitar pronta si vede.
Libra il fato i tuoi casi, e la tua sorte;
esposta al cielo, e condannata al mare
di là la vita, e di qui la morte.
Giudice l’occhio in quel momento appare,
che con Ferro celeste un guerrier forte
ti lascia in vita eternamente andare.
Don Donato Milcetti da Faenza.
Per l’Andromeda
Atto primo
Scena prima
Giunone, Mercurio.
GIUNONE
Dunque donna mortale
la mia bellezza vilipende, e scherne?
La severa Giunone,
la reina de’ nembi,
la consorte di Giove
femina vile oltraggia? e vilipesa,
e schernita rimango?
Ah pria che Febo il piè nel mar ritiri
vuò, che più d’un per me pianga, e sospiri.
Poco animato fango
con sue sozzure (o meraviglia) move
alle celesti immagini contesa;
volto cui marcir deve in sepoltura
a bellezza immortal tomba procura.
Punirò, punirò follia sì grande;
Giunon detta non sia,
se non so vendicar l’ingiuria mia.
MERCURIO
Diva, qual ira accende il divin petto?
Qual nebbia, di furore
ombra ‘l celeste aspetto?
Chi cotanto presume,
che la grande de’ numi inclita diva
oggi di pace, e di conforto priva?
GIUNONE
E di pace mi priva, e di conforto
Cassiope l’infame,
che meco osando di beltà garrire,
semina fasto in terra, in ciel martire.
MERCURIO
Cassiope (t’intendo)
d’Etiopia reina.
O superbia mortale!
Donna, ch’in beltà sale
tosto al titolo aspira di divina.
GIUNONE
Mira temeritate;
non ben paga costei
le maritime ninfe riaver deluse
per simile cagione,
a paragone con Giunon si pone;
ma cieco, ch’il piè move senza guida
tosto al piano disteso aita grida.
MERCURIO
Debile pianta, che tropp’alto sale,
al fin cade al soffiar d’aura boreale.
GIUNONE
Tu de’ numi sovrani
alato messaggero,
al gran rege, del mar or or n’andrai,
e questo l’esporrai;
che se l’onor le piace,
de la diva, de’ nembi,
un mostro il più feroce,
d’infernal possa, e di tartaree brame
(senza frapor dimora)
spinga dell’Etiopia al lito infame.
Colà vomiti, e porti
stragi, ruine, e morti.
Mai non s’arresti, di turbar quel regno,
finché assiso ad un scoglio il germe indegno
(Andromeda la figlia,
della nemica mia)
del dente suo crudel preda non sia.
MERCURIO
Diva; perdon ti chieggio,
se col mio favellar t’arreco offese;
se de la madre fu la colpa, e ‘l fallo,
la figlia non t’offese.
Che diranno le genti,
veduta l’innocenza
per man del ciel svenata,
e all’odio crudel sacrificata?
GIUNONE
Che parli d’innocenza?
L’error de la superba
ogn’un de’ suoi condanna.
MERCURIO
Mira, ch’il vel dell’odio
sovente a la ragion le luci appanna.
GIUNONE
Il mio giusto disdegno il dritto scerne;
Mercurio, ogni question se ‘n porti il vento.
MERCURIO
Cedo; sol ti rammento,
ch’il proprio d’un celeste è la pietate.
GIUNONE
Lasciar onta impunita è gran viltate.
Non s’oppone lo scoglio
sì pertinace al contrastar, dell’onda,
com’ha pietà la mente mia severa.
Vuò ch’Andromeda pera;
vattene dunque, e ‘l mio voler seconda.
Io ti prometto (e ‘l vero non ti celo)
che, se la mia vendetta oggi non segue,
sarò megera, e non Giunone in cielo.
MERCURIO
Diva, t’accheta omai;
e tregua del tuo core
porgi all’aspre tenzoni,
ch’io vado ad esequir quanto m’imponi.
GIUNONE
Ora lieta, e festosa al ciel m’invio;
la mia nemica intanto
tutte le gioie sue rinunzi al pianto.
Chi di superbia sale il giogo indegno,
non incolpi la sorte,
se poi trabocca nelle braccia ha morte.
Scena seconda
Andromeda, coro di Ninfe arciere.
ANDROMEDA
Altra ne’ vani abbigliamenti avvolta,
con aurea chioma, e inanellato crine,
ordisca rete ai cor, prigion all’alme;
io coll’asta pungente, e ‘l dardo acuto
(ove la vita con onor s’inforsa)
strazio tramo al cinghial, e strage all’orsa.
Altra sue glorie vili
si procacci col guardo;
Andromeda le sue belle, e gentili
vuol da la destra, e ‘l dardo.
Ninfe; ogn’una di voi ardita, e forte,
oggi a pugnar s’appresti
contro l’orrenda belva,
ch’empie d’orror la selva.
Cada dall’armi nostre,
e svenato, e trafitto
quel cinghial mostruoso,
per cui mesto, e dubbioso
guida gli armenti il pastorello ai paschi.
Son glorie assai maggiori
mostri atterrar, che trionfar de’ cori.
UNA DEL CORO
Sempre d’ogni tua voglia esecutrice
fia questa schiera amica;
o per erma pendice, o piaggia aprica,
per boschi, e per campagne
(ovunque andrai) ti seguirem compagne.
CORO
Di ciascuna di noi, a ogni tuo invito,
è pront’il dardo, ed è lo spirto ardito.
ANDROMEDA
O quale gioia l’anima m’ingombra
in rimirando queste
tempestate di fior spiagge odorose,
ma che vago embrion forma natura
di verdeggiante massa? qui ‘l terreno
in pianura si stende, e poco lunge
s’abbassa in valle, e là s’inalza in monte.
Qui biancheggia un ligustro,
colà verdeggia un tronco,
là sorge un bosco, e quivi sgorga un fonte.
Care selve beate
potess’io far con voi sempre soggiorno.
All’ombra d’un alloro
più agiato assai si dorme,
che sotto coltre d’oro;
e i rustici tuguri
son de’ regi edifici più sicuri.
CORO
Fra le selve non s’annida,
com’in reggia, insidia, e frode;
benché questo, e quegli rida,
nel suo cor spesso non gode;
clima rozzo, ciel silvestre
spiran sempre aure più destre.
Non ingombra pure menti
vil desio, di gemme, e d’ori;
vie più cala ne’ contenti
chi sormonta ne’ tesori;
nudità ciascun adopre,
ch’una tomba ogn’uno copre.
ANDROMEDA
Andianne, ove n’attende
de’ miei ministri l’adunata schiera;
ed or che l’orma del mio piè s’inselva
paventi ‘l mostro, e giubili la selva.
CORO
D’or le sponde e i rivi ammantino
in tu’ onor alma invittissima;
spiri l’aura soavissima,
gli augellin più dolce cantino.
Di fior vari, o prati, ornatevi,
vien Andromeda invincibile
a svenar fera terribile,
lauri, e palme a lei chinatevi.
Scena terza
Mercurio, Nettuno.
MERCURIO
Padre, e signor, de’ salsi regni, e cupi,
o dell’algose, e liquide contrade
imperator sovrano; a te mi manda
la reina de’ numi, e de le sfere;
grazia da te desia,
ch’il suo desire adempia.
E se non l’onde e i cieli,
gli umidi abissi, e gli stellanti lumi,
hanno fra lor corrispondenza i numi.
NETTUNO
Messaggero gentil, di quel bel regno,
ch’ha per mura le stelle, e tetto il sole,
Giunon che chiede, o vuole?
Brama, ch’il mar in colma oggi gareggi
co’ i zaffiri, del cielo?
O desia, che turbato
con fremito temuto
lavi ‘l volto a le stelle, e ‘l capo a Pluto?
MERCURIO
Né placido, o turbato il mar desia.
Chiede sol ella, ch’uno
de’ mostri il più feroce, il più tremendo,
ch’il mar alloggi, indirizzi immantinente
dell’Etiopia a gli arenosi liti.
Vuol ch’ad un sasso avvinta
Andromeda reina
spenga col sangue suo sete ferina.
NETTUNO
Non fia voto d’effetto il suo desire;
disponga come vuole
del salso rege, e dell’ondosa mole.
Oggi de le mie belve la più cruda,
la più feroce, ed empia
chiuderà nelle viscere colei,
ch’ella vivente aborre.
Si fian de’ corpi umani
(per servir a la dèa de’ sommi chiostri)
feretri i scogli, e sepolture i mostri.
MERCURIO
Al tuo pronto volere
ben la diva del ciel debito deve.
O qual di peste pullulante radica,
di tua grazia l’effetto,
del tuo core l’affetto,
oggi dal regno, de le stelle sbarbica.
NETTUNO
Godo, che medicina all’etra sia
l’amaritudin mia;
e che nel mio cruccioso instabil seno
posa ritrovi l’immortal sereno.
MERCURIO
Or tu imponi che tosto
esca ‘l mostro dall’umida magione,
ch’io torno in cielo a consolar Giunone.
Scena quarta
Nettuno, Proteo.
NETTUNO
A tempo giungi, o Proteo.
Deità più gradita
desiar non potea
chi del salso universo il scettro impugna.
Oggi, acciò che tu sappi,
fien gli etiopi mari
amari ascoltator d’umane strida,
tragica scena a una bellezza infida.
PROTEO
Fu quasi sempre il mar dogliosa scena,
anzi lugubre anello
a chi tentò rappresentar in quello;
e pur v’è chi fastoso, e non curante
si fida all’onde avverse.
Acciecato da l’oro
suppon gli austri frementi
zeffiretti benigni;
stima un fragile pin sodo diamante,
e le spume del mar crede macigni.
NETTUNO
Non ben paga l’umana ambizione,
di sviscerar i monti,
osa ‘l seno squarciar a la mia Teti;
ma talor poco lieti
segano i flutti i naviganti insani;
o quanti, o quanti con lor danno amaro,
ove in carne partiro, ombra tornaro.
PROTEO
Or dimmi ciò, che vuoi;
d’ogni altro algoso nume,
ch’alloggi di Nereo le salse spume,
eccomi più che pronto a cenni tuoi.
NETTUNO
Per gradir ha la dèa, ch’in ciel impera
(repentino, e veloce)
ver l’Etiopia movi
da le mie tane un mostro il più feroce.
Colà ministro mio, servo a la diva
(carnefice inumano)
squarci regia donzella a brano a brano;
e de’ purpurei suoi laceri avori
fabbrichi di Giunone
mausoleo a i dolor, tomba a i furori.
PROTEO
Farò quanto t’aggrada;
sceglier un mostro i’ voglio,
di cui più proprio albergo
fora ‘l tartareo fondo,
ch’il molle e salso mondo.
Ha coda d’angue, e branche, di leone;
sono le fauci sue fauci d’inferno,
spira lo sguardo orror, tosco la bocca;
tranne il folgor di Giove, in pezzi cade
ogni arma, che lo tocca.
Gira dovunque ei vuole
le serpentine piante,
e terrestre, e maritimo, e volante.
Questi sol col terrore
può le cittadi rivoltar in nulla,
non ch’il corpo gentil, d’una fanciulla.
NETTUNO
Or tu dunque n’andrai,
e quanto promettesti eseguirai;
ch’io penetrando i liquidi cristalli
vado a posar tra perle, e tra coralli.
PROTEO
Non sarò lento in ubbidirti, o padre.
Or all’antro m’invio,
che le squamose accoglie orride squadre.
Atto secondo
Scena prima
Astrea, Venere.
ASTREA
Dimmi, perché cangiasti,
bella madre d’amore,
i sentieri del ciel con quei del mare?
Forse per infiammare
di tua rara beltà gelido nume?
O per far, che le spume
(onuste di splender, carche di raggi
dal tuo bel guardo adorno)
empian d’invidia il sol, gli astri di scorno?
VENERE
Io qui me n’ venni per veder Nettuno,
qual spinto da Giunone
(come forse tu sai) deve oggi appunto
spedir crudo serpente
a divorar Andromeda innocente.
Troverollo, e co’ prieghi
tenterò d’impedir l’uscita al mostro,
faccia pur quest’ondoso umido chiostro
rigida e fera ogni sua deitate;
il ghiaccio nell’ardore,
la fierezza in pietate
ben sa cangiar la bella dèa d’amore.
ASTREA
Per l’istessa cagione
(bella diva) poc’anzi
ebbi lite nel cielo con Giunone;
ond’irata il piè mossi
da le superne soglie
per far passaggio in parte, ove fia d’uopo
a la regia donzella il giunger mio.
Io dèa del retto la giustizia sono;
ch’io fossi (o saria ben cosa inaudita)
com’in terra delusa, in ciel schernita.
Ma da quella, ch’io son (Vener ti giuro)
non sosterrò giammai, ch’oggi perisca
Andromeda sul fiore
dell’età sua ridente,
né ch’un drago inghiottisca
coll’equità del ciel beltà innocente.
VENERE
Te move il giusto, e me la pietà sprona
a’ sottrar dal periglio aspro, e mortale
la vergine reale.
Lo sdegno anco m’invita
a darle pronta aita,
non vuò che dov’io nacqui
peran bellezze così vaghe, e care;
non è tomba a le dive, è culla il mare.
Ah non sia mai, ch’un duro scoglio alpino,
del sangue oggi d’Andromeda lavato,
d’un macigno si cangi in un rubino.
Né fia vero, ch’un drago
(squarciando soli, e lacerando stelle)
chiuda in ventre infernal celeste imago.
ASTREA
Son le fedi del ciel fedi d’amore.
Non di rabbia e furore.
Se per mano celeste
chi è senza colpa ancor deve perire,
ove andrà l’innocente
per dimandar aiuto
al tribunal di Pluto?
La superba Giunone
dovrebbe aver riguardo
(frenando i suoi desiri empi, e crudeli)
che non son stanze di tiranni i cieli.
VENERE
Lunge menti sì felle
dal bel regno del sole, e de le stelle.
Forse forse Giunone
lieta di cotal morte non vedremo,
ch’in modo opereremo,
che l’innocente vergine non pera.
Tu col potere, et io coll’arte insieme
trarrem (schernendo chi le sfere annoia)
da spine di rigor rose di gioia.
ASTREA
Io vado; e ad esequir quanto desio
malagevol la gita anco m’alletta;
la difesa de’ buoni a me s’aspetta.
Fatto nel ciel ritorno,
e l’animo, e ‘l volere
del tonante immortal io vuò sapere.
VENERE
Ed io lo dio dell’acque
a’ ritrovar m’invio.
Oggi l’Egeo raffreni il suo rigore,
o si prepari ad avvampar d’amore.
Meraviglie sarian dure, et amare
veder due soli tramontar nel mare.
Scena seconda
Coro di Ninfe arciere, coro di Ninfe danzatrici, Andromeda.
CORO
Si rallegri il piano, e ‘l monte,
rida ‘l fior, saltelli il fonte;
vaneggi Eco per le valli
sul suo stel la fronda balli;
morto giace il fier cinghiale
(tua mercé) donna reale.
Tante voci, quante foglie
la foresta, che non scioglie?
Tante lingue, quante stelle
disnodaste o sfere belle;
per voi chiara in ogni riva
oggi Andromeda si viva.
ANDROMEDA
Ecco la fera estinta,
ecco il teschio, che quasi di Medusa,
(per meraviglia) i riguardanti impetra.
Cadde il mostro spietato,
per cui sembrar d’abisso
triste spiagge funeste
le deliziose mie care foreste.
Non più torbido è il fonte,
ma con chiari zampilli
di puro argento il bel pratel ricama.
Non più piagne, ed esclama,
timida, e sbigottita,
la villanella da una balza aita.
È franco il colle, libera la selva;
è l’armento sicur salvo il bifolco,
e all’arator non è più tomba il solco.
UNA DEL CORO
Il tuo chiaro valor, la tua virtute
(magnanima signora)
queste selve rincora,
e a gli abitanti lor reca salute.
Chi può dir del tuo strale,
chi può contar della tua destra i vanti?
Dopo lungo pugnar giacensi oppressa
de’ molossi la schiera, e degli astati
(salvo quella, ch’il piede
alla fuga fidò, non all’onore)
quando tu con gran core,
famosa arciera, e sagittaria illustre,
la saetta scoccando,
entro d’un occhio appunto
(o che bel colpo!) il mostro rio cogliesti.
Respirò la campagna
scarca del peso di sì orribil fera.
Per spiegar le tue lodi,
a null’altre seconde,
mormorò ‘l fonte, e sussurrò la fronde,
delle tue glorie i zeffiri invaghiti
altro per l’aria non sapean formare,
ch’il bel nome d’Andromeda; qual merta,
a caratter di sole,
per man del fato istesso,
nel gran foglio del ciel esser impresso.
ANDROMEDA
Non nascono gli allori
alle terrene fronti
(e gloriose sieno le prove)
se non gli pianta Giove.
Il feroce animal per me non cadde;
Giove mosse la man spinse lo strale;
senz’aita del cielo
rado giunge a buon fin opra mortale.
Ma donde ciò, che dell’estinta belva,
e del nostro gioir tace la selva?
Su su soavi omai musici cori,
con armonici strali,
dolce l’udito piaghino a’ mortali.
E di voi parte, o ninfe,
le cui piante rassembrano volanti,
colle carole accompagnate i canti.
Balletto.
CORO
Or la selva applauda al stral,
che trafisse il fier cinghial;
ogni cor lodi la man,
che svenato il stese al pian.
Colpo tal, di tanto pro
degn’arcier giammai scoccò;
come quel, ch’oggi uscì fuor
da man regia, e un arco d’or.
Fu di femina il ferir,
fu d’eroe l’invitto ardir;
nel bel sesso feminil
regnan ben cori viril.
Versa il sangue il mostro fier
su l’erboso ermo sentier;
per gran gioia, in que’ confin,
versa manna il faggio, e ‘l pin.
S’oggi ogn’un ovunque vuol
sta sicuro all’ombra, al sol,
tuo valore, tua mercé,
bell’Andromeda sol è.
Serto d’alto, e vero onor
cinga dunque il bel crin d’or;
sia al regal tuo mortal vel
destro il fato, amico del ciel.
Scena terza
Mago, Andromeda, Coro.
ASTARCO
Figlia non sbigottire,
s’improviso mi trassi a te davanti;
voler del cielo, e zelo di pietate
(anzi d’amor) qui per tuo ben mi spinse,
mi sei a cuore, amata figlia, e cara,
che dal ceppo real, onde discendi,
anch’io l’origin traggo.
Compia tre lustri appunto,
quando lo scettro, la corona, e ‘l manto
lasciai; d’intender vago
quegli arcani, che fanno
famoso un indovino, illustre un mago,
e mi ridussi in parte sì remota,
che d’uom mai non vi giunge orma, o pensiero;
ove un albergo edificato in breve,
che non invidia alle più eccelse reggie,
fortunate, e tranquille
guidate ho sempre di mia vita l’ore.
Da le cure lontan noiose e gravi,
da cui van sempre accompagnati i grandi,
a segno tal son giunto di vecchiezza
(e robusta qual vedi)
che (per vostra bontà menti divine)
del vigesimo lustro io tocco il fine.
Astarco è ‘l nome mio;
quell’Astarco son io
per magica virtù celebre, e noto;
zelante del tuo ben, figlia gradita,
del dover, dell’onor, della tua vita.
ANDROMEDA
Padre, e signor; più di stupor, che tema,
ingombra è la mia mente,
in veder qui presente
uom di tanto valor, e del mio sangue.
Vive Astarco? de’ miei
antenati famosi onor, e pregio?
Gloria dei miei grand’avi?
Vive Astarco? o beate queste luci,
ch’in te pur una volta si specchiaro,
felici queste braccia
cui si concede incatenarti il collo,
ma qual in te discerno
effetto di cordoglio, e di stupore?
Dimmi (padre) che pensi?
Fors’è presago d’alcun male il core?
ASTARCO
Sappi, ch’al bene invigilando sempre,
di te, de’ tuoi, del regno,
ieri gittai le sorti;
e vidi, ch’un influsso empio, e mortale
correr (o figlia) devi, ed oggi appunto,
non v’è (tranne sol un) riparo, o schermo,
e fuggendo s’impetra.
In questo clima sol t’è infausto il cielo.
Talché (diletta mia)
alla fuga t’accingi, e meco vieni;
se vuoi, ch’oggi il tuo piede,
che tenerello ancora
calca del mondo i campi,
nella falce di morte non inciampi.
ANDROMEDA
Oggi perir io devo,
in questo clima sol m’è infausto il cielo,
e fuggendomi teco salva sono.
O qual mi turba il core
insolito spavento?
O ciel, o dèi, ove son io, che sento?
ASTARCO
Vicino è il mal, vicina è la salute,
se tu non la rifiute.
Prendi meco il cammino:
puoi col piè calpestare il tuo destino.
S’al mio dir fé non presti,
sappi, che la gran dèa de la ragione
dal regno de’ celesti
scese poc’anzi, a mia magion se ‘n venne;
per sdegno, del tuo male,
tinta la faccia di color di rose,
la mia venuta, e la tua fuga impose.
ANDROMEDA
Infelice mio core,
anima mia, che pensi?
Dura è sempre la morte a ogni mortale,
ma in giovanile etate
durissimo è il lasciar l’aura vitale.
Canuto il legno volontier s’infiamma,
ma giovinetto amaramente abbrugia;
e stridente, e fumoso,
o per doglia, o per ira
(bench’insensato) si lamenta e piagne,
e ‘l duro suo incenerir sospira.
ASTARCO
Se tanto è grave allo spuntar dell’alba,
di nostra frale vita
ne l’Espero incontrarsi della morte,
perché l’esecuzione
della tua vita indugi?
Allor che più bramati
mancheranno i rifugi.
Dall’arco de la sorte
scoccate le sciagure
periran di magia carmi, e figure.
Quando si può si voglia;
che vicino al volere
non va sempre il potere.
UNA DEL CORO
Ah non fia ver (donna real) che sprezzi
in sì grave periglio,
del tuo grand’avo l’ottimo consiglio.
CORO
Fuggi veloce, umili ti preghiamo,
poiché se mori tu tutte moriamo.
ANDROMEDA
Chi desia la mia morte, e chi la chiede?
ASTARCO
Possente diva di pietà nemica.
ANDROMEDA
Dunque s’il ciel la vuol, come la fuggo?
ASTARCO
A la fuga, e a la morte il ciel t’appella.
ANDROMEDA
In ogni loco morte è sempre morte.
ASTARCO
Chi fa quel, ch’il ciel vuole
perir giammai non suole.
ANDROMEDA
Si dispogli d’onor chi morte teme.
ASTARCO
Brutte son l’ore de la vita estreme.
ANDROMEDA
Non peccai contro voi supreme menti,
a che bramar il fin degl’innocenti?
ASTARCO
Ahi ch’il tempo se ‘n vola,
e un’oncia di momento
vale un peso del mio, e tuo tormento.
Astarco il tuo grand’avo
è quel, che t’ammonisce, e ti consiglia.
Or che risolvi o figlia?
ANDROMEDA
Risolvo, o padre, di voler morire,
poiché la morte mia al cielo aggrada;
sovra ‘l mio capo cada
la sentenza fatal, che nulla temo.
So che nel punto estremo
la mia innocenza griderà sì forte,
che potrà fin ne cieli, e negli abissi
sbigottir gli astri, e spaventar la morte.
ASTARCO
O infelice, che sento?
Lasso! qual scampo all’innocente or resta?
Gittata è l’opra, e la fatica mia,
ch’a rapirla non val forza, o magia.
ANDROMEDA
Padre il mio duro fin, deh, non t’aggreve,
al fonte de la morte ogn’uno beve.
CORO
O ciel, o dèi, aita a tanti guai;
e ‘l gel d’ostinazion rigida, e dura,
ch’a la regia donzella il seno indura
con calor di pietà struggete omai.
ASTARCO
Fuggi, o rimanti, figlia,
tanta pietà di te l’alma m’ingombra,
ch’io vuò sempre seguirti, e corpo, ed ombra.
ANDROMEDA
Deh non più pianti, o padre,
o fida schiera amica!
Per le lagrime vostre,
gonfie d’affetto, e d’amarezza piene,
più fera a nuoto la mia morte viene.
Andianne al tempio a render grazie al cielo,
dell’estinto cinghiale.
ASTARCO
Et a pregarlo con divoto zelo,
che l’ira freni al tuo destin mortale.
CORO
O ciel, o dèi, aita a tanti guai;
e ‘l gel d’ostinazion rigida, e dura,
ch’a la regia donzella il seno indura
con calor di pietà struggete omai.
Scena quarta
Giove, Giunone.
GIOVE
Chi sovra gli altri impera
dée con giusta bilance
l’opre contrapesar di cui si sia,
e a i devoti, e a i ribelli
rettamente partir grazie, e flagelli.
Ma per lo più dev’esser mite un dio;
troppo sono possenti
le mondane cagioni
da far dal dritto traviar le genti.
Giunon placida riedi;
frena le voglie tue crude, e rubelle,
nidi non son di ferità le stelle.
L’ire, e gli sdegni tuoi vadan altrove,
stan con Pluto le furie, e non con Giove.
GIUNONE
Può ben Giunon Giove lasciar, e ‘l cielo,
ma lo sdegno lasciar non può Giunone.
La sete della rabbia non estingue
altro liquor, che l’inimico sangue.
Pria negli abissi splenderan le stelle,
e tufferassi il sole in Flegetonte;
sarà prima di furie il ciel adorno,
che privo di vendetta il mio gran scorno.
GIOVE
Ah non sia ver, che morte,
per adornarne un drago,
dell’Etiopia ‘l fior recida, o sterpe;
né ch’a un corpo reale,
di tomba d’oro in vece,
formi sozza magion ventre di serpe.
Diva segui ragion, tempra il rigore,
regna in ciel il dover, non il furore.
GIUNONE
Seguo ragion, mentre castigo i rei.
GIOVE
Non è rea chi tu sai.
E ‘l punir gl’innocenti è tirannia.
GIUNONE
A’ grandi il tutto lice,
a’ dèi nulla disdice.
GIOVE
Oprano sempre rettamente i numi.
GIUNONE
Or dunque operar male non poss’io.
GIOVE
Allo sdegno crudel, ch’in te discerno
diva non sei del ciel, ma dell’inferno.
GIUNONE
Nella mia mente è rea chi morta voglio.
GIOVE
La sua bella innocenza in seno accoglio.
GIUNONE
Ove l’odio comanda il giusto serve.
GIOVE
Se vaga d’odio sei,
lascia i buoni, odia i rei.
GIUNONE
O innocente, o innocente, o buona, o ria,
diva qual io mi sia,
dell’abisso, o del cielo,
(rabbia pazienza la giustizia, e ‘l zelo)
morirà la malvaggia.
GIOVE
Ben se’ tu poco saggia.
Tanto di te presumi? e dove lasci
l’onnipotenza mia? e non t’avvedi
chi se’ tu chi son io?
Non sai, che de le stelle, e dell’inferno,
de la terra, e del mar l’arbitro sono?
Io con un cenno sol movo, ed acqueto
i nembi, e le procelle,
e lampeggiar fo il sol, rider le stelle.
Ergono riverenti al nume mio
d’ogn’intorno le genti altari, e tempi.
Non v’è cosa creata,
o spirante, o insensata,
che non tema di Giove onnipotente,
a questa destra il folgore s’aspetta;
e delle deitati
niuna pareggia il mio sublime stato;
da me dipende la natura, e ‘l fato.
GIUNONE
Signor, se ‘l tutto puoi
(non m’annoiar tu più) fa’ ciò, che vuoi.
Movi in aiuto a le deserte arene
(che tardi omai?) col folgore tonante;
una femmina vil vesti di gioia,
e una diva immortal cingi di pene.
L’infame a morte togli;
teco la guida, e per maggior sua gloria
inciela i mari, e imparadisa i scogli.
GIOVE
Non più diva non più; quel ch’è prescritto
de la regal fanciulla
ne’ registri del cielo il fato ha scritto;
voler no ‘l cassa, e niun poter l’annulla.
Atto terzo
Scena prima
Astrea, Venere, Mercurio, Giove.
ASTREA
Io spinsi il dotto mago
a la nobil donzella;
e l’animo presago
spera dal suo valor lieta novella.
VENERE
Io sossopra voltai l’onde spumanti;
ma da Nettuno allontanato il mostro
altro far non potei, che del suo chiostro
rendermi servi i flutti, e i numi amanti.
ASTREA
La giustizia è possente;
spero che giunga a fine il mio desire,
chi seco ha la ragion non può perire.
VENERE
Anch’io ciò spero; è la bellezza un fonte,
ch’ogni alma accende d’amorosa sete;
trovar non puossi a un cor più dolce rete,
ch’un labbro porporin, stellato un fronte.
ASTREA
Di Giove ancor non ho il parer compreso,
ch’irato, e affettuoso,
tra ‘l ragionevol senso, e l’amoroso,
la superba Giunone il tien sospeso.
VENERE
Vedrai, ch’anch’egli a favorir rivolto
sarà ‘l nostro parere,
sprezzar il giusto, e ‘l bel non è dovere.
ASTREA E VENERE
Dolce speme il cor allettane;
venga men
lo venen,
di Giunon, ch’in ciel infettane.
Lieta fa la donna amabile;
varia ancor
astro tenor;
la fortuna non è stabile.
Ben contenti sien i superi,
che ragion
da un dragon
la real vergin ricuperi.
Da quel ciel dunque il vel nubile
fugga a vol;
ogni duol
si converta in gaudio, e ‘n giubilo.
MERCURIO
Dive festose, e liete,
ond’il contento, e ‘l gioir vostro avete?
Forse Giuno placati i suoi furori,
per la morte d’Andromeda infelice,
le sue gioie comparte ai vostri cori?
Ah ben è ver, che dell’irata dèa
ammorzar si dovea la rabbia ardente,
ma non col sangue mai d’una innocente.
Infelice donzella!
Poc’anzi co’ begli occhi,
di più soli ornò il mondo,
e col bello cangiò, del vago viso
la terra in paradiso,
or coll’ossa spolpate, e con il sangue,
del mar crudo, e maligno
lastrica un lido, e imporpora un macigno.
GIOVE
Morta non è la regia figlia ancora,
né ‘l tonante, del ciel vuol, ch’ella mora.
Or chi fia tanto audace, che d’opporsi
al genio mio si prove,
s’onnipotente è Giove?
Vanne Mercurio or ora,
e ‘l cavalier dal corridor alato
(Perseo) ritrova, e dille,
ch’immantinente a la deserta spiaggia,
che l’infelice Andromeda raccoglie,
l’armi rivolga, e ‘l core.
Il drago ancida, avvivi l’innocenza;
distrugga l’impietà, Giove consoli,
e la vergin dolente a morte involi.
MERCURIO
Di servirti (o signor) tanto m’appago,
tanto de la salute
dell’innocente vergine son vago,
ch’ad eseguir il tutto
volo con maggior fretta,
ch’il rattissimo piè d’una saetta.
ASTREA
Signor; più rettamente
oprar non si potea;
sorte saria troppo spietata, e rea,
che per pascer serpenti
generasser le genti;
e insopportabil fora, l’innocenza
(ch’abbellisce del ciel l’eterno chiostro)
veder gioco di morte, esca d’un mostro.
VENERE
Ah con ragione custodir ben devi
(padre, e signor) la nobile donzella;
che quanto vaga, e bella,
innocente non meno,
merita non, ch’un drago,
ma ch’un cieco fanciul le piaghi il seno.
GIOVE
Quanto fei, quanto volli
(per dover, per pietate) a me diletta;
ma la gioia maggiore
or si fa nel mio core,
ch’ho i desir vostri consolati, o dive.
Già scende all’erma riva il guerrier forte,
il celeste campione,
ed estinto il dragone
la donzella real sottraggo a morte.
Or ivi, ch’indugiate?
Vivete liete, e su nel ciel tornate.
ASTREA E VENERE
Diamo a Giove tutt’amor
ogni gloria, ed’ogni onor;
egli giusto, egli leal
tutto regge e tutto val.
Senza Giove fora il ciel
poco buon, e poco bel;
fanne tu fede Giunon,
che la vuoi contro ragion.
Diamo a Giove tutt’amor
ogni gloria, ed’ogni onor;
egli giusto, egli leal
tutto regge, e tutto val.
Scena seconda
Ascalà.
O patria, o regno, o figlia? o sovra ogni altro
colmo d’affanni, e di calamità
dolente, e miserabile Ascalà.
Io de’ fidi il più fido
alla reggia funesta,
io sventurato sono
nell’esterminio suo vivo rimaso?
O fiero giorno, o memorabil caso.
Deh mi s’apra ‘l terren sotto le piante,
acciò che quella requie,
che mi nega de’ vivi il duro regno,
a me doni, ed apporti,
la region de’ morti.
Infelice reina
a che il ciel ti destina?
A saltellar d’un serpentino ventre
le voragini cupe,
di gloria d’una reggia, ludibrio d’una rupe,
fu celeste furore,
o pur umano errore,
ch’a questa patria spinse orribil drago
ch’empiendola di lutto
non lasciò volto lieto e ciglio asciutto?
Voce fu dell’abisso, o pur del cielo
quella, che dall’oracolo s’intese,
che per scansar l’offese,
dell’orrido serpente,
le si dovesse dar a divorare
(a un duro scoglio incatenata in mare)
del re la figlia, Andromeda innocente?
Fu zelo di pietate
(donna virile, e forte)
che volontaria ti condusse a morte?
Ah che per lo risparmio di tua vita,
e del tuo corpo virginale, e degno
era una città nulla, e poco un regno.
Ad ogni modo la tua patria cade.
Senza del tuo sostegno
vaneggiano le genti,
traballan gli edifici.
Le matrone, e le vergini infelici
(orfane del suo sole
ch’all’occaso, di morte ora soccombe)
urtano ne’ feretri,
inciampan nelle tombe.
Bandì dal nobil suo carcer terreno
la grand’anima, Astarco,
trafitto di sua man l’antico seno.
L’afflitta genitrice
per soverchio dolor è fatta insana;
e ‘l mesto genitore
su le piume real languendo more.
Ahi nostra vita di miserie piena,
a noi (fuor che nel ciel) non mai serena.
Ben fu del tuo regnar la condizione
malvaggia, empia, e ferina,
sfortunata reina!
Avendoti a servir per gemme, ed’ostri
ferri, e macigni, e per tua reggia i mostri.
Vedransi (ahi dura vista)
oggi dell’ocean le salse vene
trionfar di più soli;
di stille di rubino
tempestate l’arene;
d’un bel corpo divino
sazi ferini orgogli;
di ciocche d’oro inanellati i scogli.
Addio patria infelice!
Reggia funesta addio.
Lo scettro, che di te regger poss’io
(lieto) ad altri rinunzio.
Altri pur goda il transitorio onore
infelice è il regnar ove si more.
Scena terza
Andromeda al sasso.
Nacqui, convien morire;
bocca, che sugge di due mamme il latte
non può fuggir l’assenze della morte.
Chi nella cuna inciampa
finalmente a cader va nella tomba.
O vita quai n’apporti
fuggitivi diletti,
s’appena nati se n’andiam tra morti.
Ahi mondo lusinghiero,
quanto son vane le grandezze tue!
Poco dianzi posai su regia sede,
e col piè calpestai dorato soglio,
ora premo l’arena,
ed è mio trono un scoglio.
De’ genitori miei, del regno mio
la sola gioia fui, l’unico oggetto,
or la delizia d’un dragon son io.
O ciel, che fai, che tardi,
che per pietà spietato
con un fulmin il sen non mi percoti,
prima, che d’un serpente
mi franga il duro dente?
Ah ch’il cielo mi crede
per soverchio martir cangiata in sasso;
e le saette sue son de’ maligni
bene spesso flagel, non de’ macigni.
Andromeda che pensi?
Se tu pensi al morire
raddoppi il tuo martire.
S’all’inclemenza pensi de le stelle
ti fai del ciel ribelle.
Se la mente rivolgi al regno antico,
al fine per natura
cangia il regno chi regna in sepoltura.
Se t’affisi nel fiore di tua vita,
sul più bel del germoglio arido fatto,
per fatal cruda sorte
sempre la vita nostra
(ancor ch’acerba a gli anni)
è matura a la morte.
O mari, e che vi feci? ch’una belva,
perché mi divorasse, generaste?
Dite, son così degni i vostri mostri,
che meritin per cibo i corpi umani?
E voi onde crucciose, e flutti insani,
ch’oggi del sangue mio tanto gioite,
in che Andromeda mai v’offese, e spiacque?
Lassa: che per tributo il mar desia
i torrenti di sangue, e non più d’acque.
Misera, e sfortunata,
a chi mi volgo per rifugio, o scampo?
Alle pietose genti,
s’a quest’infausta arena
altri non giungon mai,
che procelle, o serpenti?
Dirò le mie ragioni a questa rupe,
ch’oggi del sangue mio debb’esser tinta?
S’altro senso non ha che di tenermi
al suo marmoreo sen stretta, ed avvinta?
Chiederò a’ venti, ed a quest’onde aita?
Se col volo, e la fuga
io son da lor schernita?
A te mi volgo, o cielo;
a te ricorro co’ la mente in modo,
che beatificati i pensier miei
spero addolcir l’aspre mie doglie, e dure,
e di gloria vestir le mie sventure.
Già l’orecchio mi fere
del fero drago il sibilo tremendo;
ma tua pietà m’affida,
che, se ben del mio corpo
pia sepoltura un mostro,
pace lo spirto avrà nel tuo bel chiostro.
Qui esce il drago.
Scena ultima
Perseo, Andromeda, Giove, coro de’ Dèi.
PERSEO
Non temer, non temer donna reale;
il cor rinfranca e la beltà smarrita,
ecco la mia vittoria, e la tua vita.
Segue la battaglia, e morte del mostro.
PERSEO
Ora spezzar conviene
queste dure catene.
Itene indegne all’infernal fucine,
ch’ardiste imprigionar membra divine.
Non più mesta, e pensosa,
ma ridente, e festosa (o bella mia)
rasserenati de’ begli occhi i rai
(in cui amor s’asconde)
fa di più soli lampeggiar quest’onde.
Mira te sciolta, e que’ legami rotti,
che fur delle tue braccia aspri monili;
ma mira ancora come l’alma, e ‘l core
co’ i lacci del tuo crin m’annoda amore.
Morio per la mia man l’orribil fera;
mira fatto amoroso agonizzante
(colpa de’ tuoi begli occhi) il trionfante.
O miracolo novo!
Da un duro scoglio ogni mio ben vien fora,
e un avanzo di morte m’innamora.
ANDROMEDA
Celeste eroe; la tua bontà poteo
a un sepolcro spirante
furar questo cadavere, che solo
di vivo ha in lui la maraviglia, e ‘l duolo,
la tua bontade ancora
(poich’i defunti idolatrar ti piace)
qual più l’aggrada, le dia requie, e pace.
PERSEO
Sarà tua requie, e pace
l’esser oggi nel ciel mia diva, e sposa;
riedi, deh, riedi omai lieta, e festosa.
Non ingombri, od oltraggi
la bella faccia tua doglioso velo;
crederanno le genti,
mirando il tuo bel viso,
che sia loco di pene il paradiso.
ANDROMEDA
O ciel, o dèi, e che favor son questi?
Passar dai scogli a i numi,
dal feretro a le nozze,
da la morte ad’amor, dal mar al cielo?
Così va chi con scudo, d’innocenza
può i perigli affrontar del mondo infido.
Ma qual grazie (o signor) saran bastanti
a riconoscer mai favori tanti?
GIOVE
Al ciel alme gradite;
de’ vostr’almi imenei
pronube sian le stelle, auspici i dèi.
Venite omai venite;
in questi seggi aurati
chiedonvi amici i numi, amici i fati.
Il gran Giove il consente;
Giunone qui presente
(al fin fatta pietosa alle mie preci)
arride ai vostri onori, anime liete.
GIOVE
Godete omai godete
entro gli eterni scanni
l’infinita mercé, de’ brevi affanni.
CORO
Godete omai godete
entro gli eterni scanni
l’infinita mercé, de’ brevi affanni.
Fine del libretto.